Anche quest’anno contiamo le donne uccise (e sono tante… troppe, per sopportarne la conta senza che ci colga la ribellione dentro) dall’assurda violenza di uomini che ci riesce difficile ascrivere ad una qualche categoria: folli, malati, delusi, violenti… No, semplicemente assassini.
Il fenomeno non si può neppure inquadrare semplicisticamente in analisi psico-sociali. Si dice che sia un problema “culturale”, ma, a voler capire meglio, se per cultura si intende il portato del sentire collettivo che connota un particolare tempo storico in un determinato luogo geografico, allora il mondo intero (poiché il fenomeno è planetario), è gravemente malato, si è pervertito, si è capovolto rispetto ai processi di sviluppo, ha deviato dal suo orizzonte di umanizzazione, unico traguardo di senso di ogni progresso. Ogni volta che un essere umano esercita violenza gratuita nei confronti di un essere più debole, l’intera umanità si disintegra, perde la sua stessa natura degradandosi nel suo contrario che non è la bestialità, no, perché tra gli animali la violenza risponde ad una qualche ragione che potrebbe essere riconducibile, in ultima analisi, alla sopravvivenza della specie, dunque ancora nell’ordine della salvaguardia della vita. Ma se un essere umano maschio uccide un essere umano femmina, che rappresenta la rigenerazione e dunque la salvaguardia della vita, e in molti casi di femminicidio è la madre dei suoi figli (e l’assurda perversione si spinge fino all’uccisione di quegli stessi figli innocenti), allora davvero siamo ancora una volta di fronte al fenomeno epocale della malvagità elevata ad odio, un sentimento distruttivo della vita che si insedia nel cuore di alcuni individui che concepiscono di poter ucciderne altri. Una sopraffazione maligna che la filosofa Simone Weil spiegava nei termini di un vuoto del soprannaturale, una perdita della capacità di orientare il proprio pensiero verso il bene.
Stando così le cose, siamo tutte e tutti chiamati in causa perché se il male, tanto perverso quanto ottuso, dilaga, negando la vita fino all’assassinio, ancor più bisogna disseminare capillarmente azioni e pensieri che promuovano la vita, che la riconoscano, la difendano, in tutte le sue forme e manifestazioni.
Qualcuno potrebbe obiettare che così la prendiamo alla larga, divaghiamo senza focalizzare concretamente la questione. Tutt’altro! Nessuna malattia può essere diagnosticata limitandosi ai sintomi, né può guarire un organo senza che sia sanato l’intero corpo. Il male colpisce l’intero organismo in ogni sua dimensione. La risposta al male che attanaglia la società deve attraversare ogni ganglio, ogni arteria, ogni organo, ogni umore fisico, mentale e spirituale. In questo senso l’impegno è di natura culturale, investe cioè tutti i campi nei quali si esprime e si realizza l’essere umano in quanto essere sociale, relazionale. Imparare la relazione: questo il compito da assumere in quanto esseri umani. Il primo canale è quello dell’imitazione: i neuroni a specchio captano i messaggi relazionali prima di ogni elaborazione riflessa. L’empatia si apprende per esperienza empatica. La comunicazione dunque non è faccenda mediatica, prima ancora è dimensione etica. Chi usa strumenti mediatici per qualsiasi scopo, deve sapere di avere un’enorme responsabilità, perché crea modelli emulativi, stili relazionali, orienta i comportamenti, e se non ha la chiara coscienza che devono sempre corrispondere ai criteri del vivere bene e della buona vita, si rischia di accrescere vivai di cattiva semenza che prima o poi infesta ogni campo.
Se la violenza sulle donne è questione culturale, come non considerare il peso del linguaggio nel veicolare modelli culturali in contrasto con i discorsi d’odio troppo facilmente diffusi attraverso i canali telematici? Come non contrastare il linguaggio sessista fatto di luoghi comuni denigratori delle donne, della cui gravità si è persa la percezione, incistati come sono in forma mentis, e dunque in abiti comportamentali? Come lasciar correre sul dilagare del linguaggio fallocentrico col quale si intercala la comunicazione a partire da quella familiare? Come accettare che giornalisti, intellettuali, politici, si ostinino a non voler riconoscere come errore concettuale, oltre che grammaticale, l’uso del genere maschile per l’attribuzione di titoli professionali o istituzionali alle donne, rafforzando il pregiudizio che ai livelli alti ci si giunga solo se maschi? Chi parla pubblicamente esercita il potere della parola, straordinaria prerogativa umana che determina progresso democratico solo se esprime la capacità di correlare la parola al pensiero, il pensato alla realtà, il discorso alla determinazione del reale. In ultima analisi si cresce culturalmente, se si esercita il logos, il discorso filtrato attraverso il pensiero edificante, creativo, in quanto capace di esprimere la volontà buona in grado di cooperare per un mondo bello in cui vivere. L’uso della parola umanizzante, aliena da qualunque forma di discriminazione, a partire da quella di genere, è responsabilità di chiunque apra bocca. I personaggi che pronunciano comizi e discorsi, che tengono in mano un microfono, che partecipano ai talk-show, dovrebbero avere la consapevolezza di essere legittimati al potere della parola solo entro i limiti di un discorso costruttivo e propositivo, anche quando si avvale della critica, della denuncia, del contraddittorio e persino della conflittualità, se costituisce un’occasione di confronto rispettoso. Virtù rara, tale capacità di dialettica, eppure indispensabile alla vita stessa della democrazia che si fonda non tanto sulla uguaglianza e la parità, categorie che paradossalmente hanno creato sperequazione tra i generi, quanto piuttosto sul riconoscimento della diversità come valore che presuppone l’ascolto, la considerazione, il rispetto. Su questo esercizio si dovrebbero confrontare i comunicatori mediatici, sensibili al vincolo morale di una parola rispettosa dell’altro come dell’altra, capaci di suscitare riflessioni aperte, interrogativi fondati, piuttosto che scadere nel linguaggio becero, stimolare il pregiudizio, semplificare la riflessione, mortificare o, peggio, manipolare il bisogno di verità. Lo esigono per primi i giovani che in questi giorni riempiono le piazze per reclamare nuovi modelli di relazione su cui fondare una nuova politica, un nuovo modo di coesistenza umana che riattivi il circolo della vita: linguaggio-pensiero-relazione, una complessa rete di interconnessioni umane che costituiscono il modello culturale che impronta una comunità, a partire da quella primigenia tra maschio e femmina violando la quale, si spezza il circolo, si nega la vita.
Stefania Macaluso













































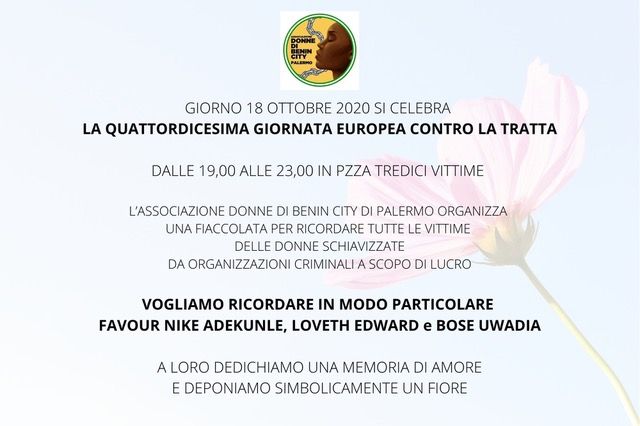































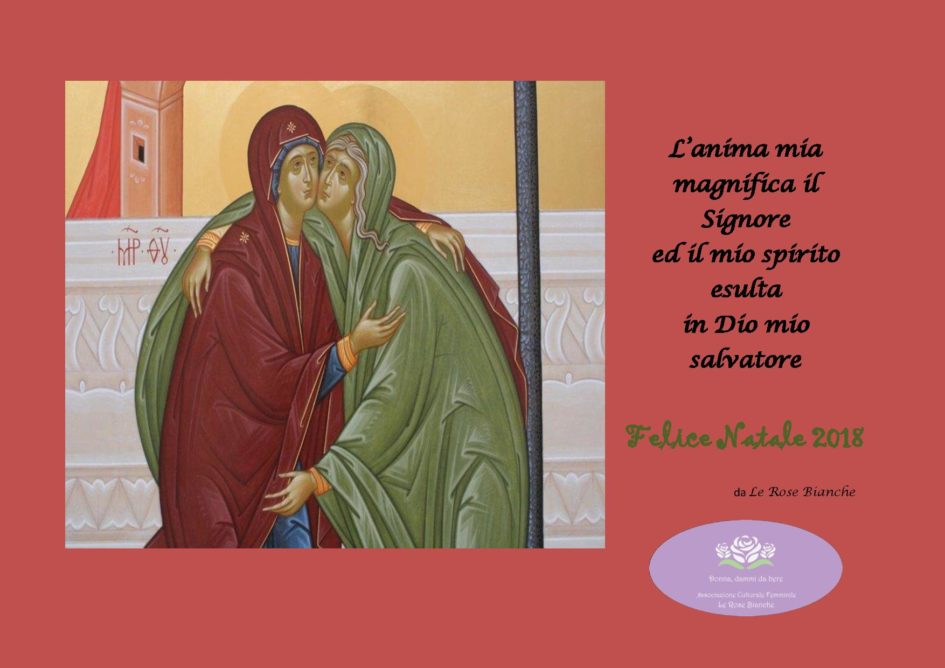




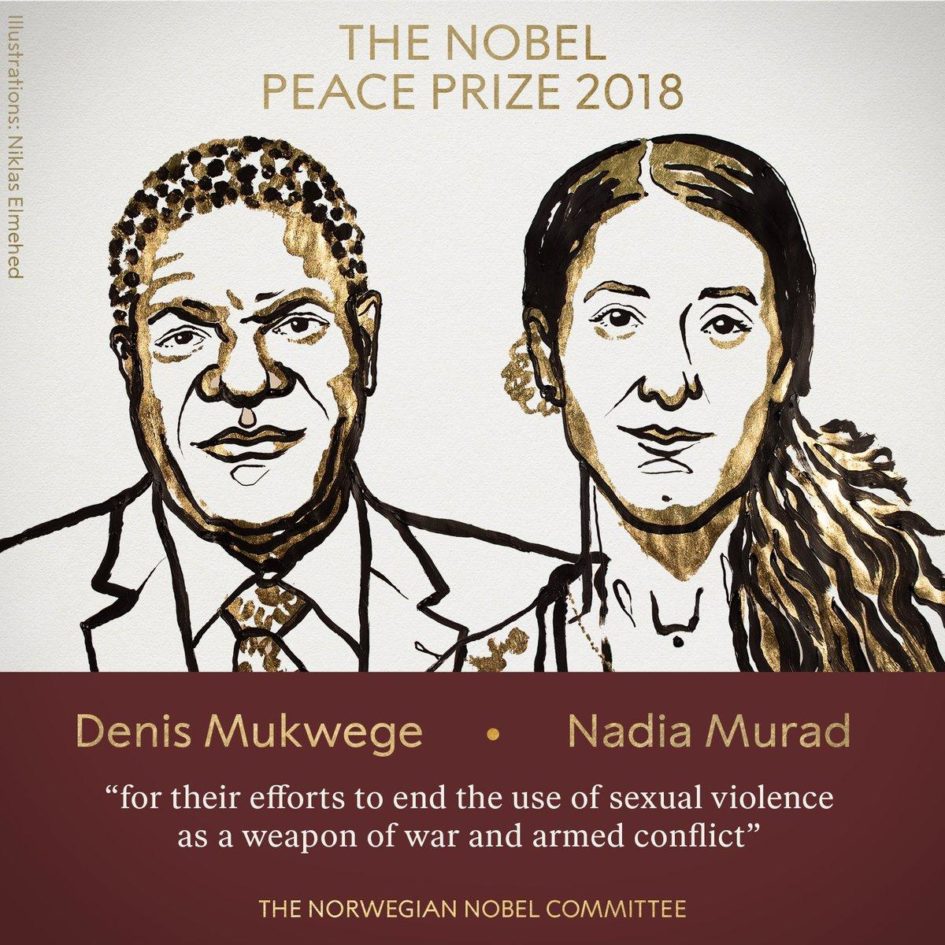





















Lascia un commento